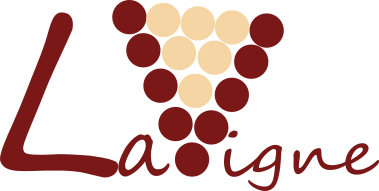“Se sei triste, metti un po’ di rossetto e attacca.” Coco Chanel, come sempre, non sbagliava. In quella frase apparentemente frivola c’è tutta la potenza di un gesto che attraversa secoli, civiltà, lotte, mode e generazioni. Il rossetto non è solo trucco: è un rito, una corazza, una firma personale, una piccola ribellione quotidiana contro l’opacità del mondo.
Non saprei contare le volte in cui l’ho messo solo per sentirmi “più me stessa”. Anche in casa (Covid, ne avete qualche vago ricordo?). Anche senza un appuntamento. Anche per telefonare. Perché non c’entra con chi ci guarda: il rossetto parla prima di tutto a noi stesse. È un segno che ci racconta — anche quando decidiamo di non metterlo.
E non a caso, da millenni, lo portiamo addosso con un significato che cambia e si evolve. Dalla Mesopotamia al Rinascimento, dal rosso delle suffragette al bordeaux delle dive anni ’90, dalle labbra noir punk alla palette neutra delle passerelle di oggi, il rossetto è sempre rimasto lì, testimone discreto delle trasformazioni della femminilità.
Maison come Chanel, Dior, Guerlain, Lancôme e Estée Lauder hanno costruito vere e proprie mitologie attorno a uno stick colorato, capace di contenere in sé molto più che pigmento: c’è storia, c’è potere, c’è identità.
Ecco perché vale la pena raccontarla, questa storia. Perché parla di noi, più di quanto immaginiamo.
Dall’antichità al Rinascimento: il potere nelle labbra
Il rossetto nasce molto prima delle passerelle e dei beauty counter. Le sue origini affondano nelle sabbie della Mesopotamia, dove uomini e donne trituravano pietre semi-preziose per colorarsi le labbra con impasti scintillanti. Nell’Antico Egitto, era un gesto quotidiano: Cleopatra amava il carminio ottenuto dalla cocciniglia e lo mescolava con pigmenti dorati. Più che seduzione, era potere. Truccarsi era un modo per richiamare la protezione degli dèi, un’azione rituale, simbolica, assolutamente paritaria tra i sessi.
Anche in Grecia e a Roma le labbra colorate segnavano status, ma il confine tra piacere estetico e giudizio morale era sottile. Le donne “rispettabili” dovevano mostrarsi sobrie; il trucco vistoso era associato alle etère, alle artiste, alle cortigiane. Eppure, proprio lì, tra il perbenismo e il desiderio, il rossetto iniziava a raccontare la sua ambiguità affascinante.
Nel Medioevo il pigmento sulle labbra fu considerato sospetto, se non addirittura diabolico. Troppo sensuale, troppo audace. Le donne preferivano il pallore etereo, e il rossetto — quando usato — era segreto, nascosto, quasi colpevole.
Fu il Rinascimento a riportarlo alla luce del giorno. La bellezza tornava a essere virtù, e colorare le labbra con miscele artigianali a base di cera, pigmenti naturali o — ahimè — piombo, diventava pratica diffusa tra le dame delle corti italiane, francesi e inglesi. Non era ancora cosmetica come la intendiamo oggi, ma il gesto era già lo stesso: disegnare la bocca significava scegliere come raccontarsi.
Rossetto e scandalo: quando il trucco fa paura
Pochi oggetti, nella storia, sono stati al tempo stesso così desiderati e così temuti. Il rossetto ha avuto spesso una reputazione ambigua: tanto potente da attrarre, quanto destabilizzante da censurare. Perché tingersi le labbra non era (e non è) mai un gesto neutro. Dice qualcosa. Anzi: grida qualcosa, anche quando è solo un filo di colore.
Nel Seicento inglese, ad esempio, le donne che si truccavano potevano essere accusate di stregoneria. In Francia, la corte di Versailles usava il maquillage come status symbol, ma chi lo sfoggiava fuori dai salotti dorati rischiava di essere giudicato scandaloso. Durante l’età vittoriana, il rossetto era associato esclusivamente a donne “di facili costumi”. In molte culture, per secoli, una bocca colorata equivaleva a un’intenzione disinibita, a un carattere troppo autonomo, a una femminilità difficile da controllare.
Ecco perché, da sempre, il rossetto è molto più di un semplice prodotto di bellezza. È uno strumento identitario. Un codice. Una dichiarazione.
Non a caso, nel Novecento, quando le donne iniziano a prendere parola nello spazio pubblico, il rossetto torna sulle labbra. Ma non come ornamento: come gesto politico. Saranno le suffragette, negli anni Dieci, a sfilare con il rossetto rosso come simbolo di forza e autodeterminazione. Non era solo trucco: era un’affermazione.
Da lì in poi, la storia del rossetto si intreccia indissolubilmente con quella dei diritti, dei desideri e delle trasformazioni della donna contemporanea. E il mercato — ovviamente — se ne accorge.
Il rossetto moderno: nascita e rivoluzioni
Se il rossetto per secoli è stato fatto in casa, mescolando pigmenti con grassi animali, cere e additivi naturali (non sempre sicuri), è solo a fine Ottocento che la cosmetica diventa industria. E con lei, anche il rossetto comincia a prendere forma nella versione che conosciamo oggi.
Nel 1884, a Parigi, viene commercializzato il primo rossetto in stick avvolto in carta di seta — un oggetto ancora lontano dalla nostra idea di pack moderno, ma già irresistibilmente glamour. Negli anni ’20 e ’30, con la nascita del cinema muto e poi sonoro, le labbra diventano protagoniste assolute. Il rossetto entra nell’immaginario collettivo grazie ai volti delle dive: Clara Bow, Jean Harlow, Greta Garbo, e poi Marlene Dietrich e Rita Hayworth. Le labbra disegnate con precisione chirurgica diventano un marchio, un’arma scenica, un’identità visiva.
A contribuire alla diffusione di massa ci pensa Helena Rubinstein, una pioniera del beauty, seguita da Elizabeth Arden, Max Factor e infine Revlon, che negli anni ’40 lancia una linea di smalti e rossetti perfettamente coordinati: una novità assoluta, che fa impazzire le donne americane.
Ma è durante la Seconda Guerra Mondiale che il rossetto compie una delle sue rivoluzioni più silenziose (e significative). Con gli uomini al fronte, le donne entrano nelle fabbriche e negli uffici. E cosa fanno? Mettono il rossetto. Non per sedurre, ma per mantenere un senso di identità, forza, presenza. Il rosso intenso diventa parte dell’uniforme morale. Lo stesso Churchill — sì, proprio lui — lo definisce “essenziale al morale femminile”.
E poi c’è Chanel, ovviamente. Coco lancia il suo primo rossetto nel 1924, ma è nel dopoguerra che la maison perfeziona l’idea di rossetto come gesto di stile puro. Minimal, intenso, elegante. Come tutto ciò che porta il suo nome.
Il resto è storia — e packaging. Con l’avvento della pubblicità e della cultura pop, il rossetto entra nei bagni, nelle borse, nei film, nei videoclip. Cambiano i colori, le formule, le texture. Ma il significato resta lì, intatto: un bastoncino di potere da tenere in mano.
Anni ’70 – 2000: punk, pop e provocazione
Se negli anni ’50 il rossetto era sinonimo di femminilità impeccabile — labbra a cuore, rosso ciliegia, specchietto da borsetta — dagli anni ’70 in poi cambia tono, forma, intenzione. Non è più solo seduzione: è messaggio. È un codice da leggere e decifrare.
Le labbra si tingono di nero, viola, blu metallizzato. I colori diventano sfida, identità, rottura delle regole. Il rossetto viene strappato alla norma femminile borghese e portato altrove: nei club, nei concerti, sulle guance dei punk, sulla bocca di chi non vuole più corrispondere a un ideale preconfezionato.
David Bowie, a Siouxsie Sioux, a Boy George, a Prince. Ma anche Madonna, che negli anni ’80 fa del rossetto rosso sangue una delle sue armi iconiche, sovrapponendo religione, sessualità e pop culture in un unico gesto.
Negli anni ’90, l’estetica cambia di nuovo. Il rossetto si fa marrone, bordeaux, quasi noir, spinto da un ideale più androgino, grunge, sofisticato. È il decennio di Winona Ryder, Kate Moss, dei rossetti Mac in tonalità Spice o Paramount, delle matite visibilmente più scure del rossetto. Tutto è vibrazione urbana, consapevole malinconia.
Poi arriva il 2000 e con lui l’era del gloss. Effetto bagnato, zero pigmento, massimo riflesso. Le labbra diventano luccicanti come bolle di sapone. È la decade Y2K, dei gloss roll-on, di Britney Spears, Christina Aguilera e delle estetiche iperfemminili che oggi stanno vivendo un inatteso revival.
Ma nel frattempo, qualcosa è cambiato: il rossetto, ormai, non ha più un solo significato. Non dice solo “sono femminile”, “sono sexy”, “sono elegante”. Dice: “sono quello che voglio essere oggi”. È diventato linguaggio. E chiunque può usarlo.
Il rossetto oggi: tra genderless, consapevolezza e nuovi riti
Nel 2025 il rossetto non ha più un solo volto — e nemmeno un solo genere. È passato attraverso i secoli, le guerre, i tabù, i glitter, ed è arrivato qui: sulle bocche (e nei beauty case) di chiunque voglia usarlo come un’estensione di sé.
Il rossetto oggi è genderless. È parte del trucco e parte del gioco. Lo indossano donne, uomini, persone non binarie. È visibile su TikTok nei tutorial di giovani creator con milioni di follower, ma anche sulle labbra di chi semplicemente, ogni mattina, sceglie di guardarsi allo specchio e dire: “Va bene così”.
Le maison, da Chanel a Dior, da Fenty Beauty a Hermès, hanno intercettato questa evoluzione. Le formule si fanno più clean, vegane, spesso refillabili. Il lusso diventa sostenibile, il packaging è un oggetto di design, il gesto diventa rituale consapevole.
I colori? Tutti. Dal rosso pompeiano al beige rosato, passando per prugna, arancio, corallo e il nude personalizzato che non è più “uno per tutte”, ma “uno per te”.
Oggi il rossetto è un accessorio, un’espressione, un dettaglio che può cambiare l’umore (e la postura). È anche una scelta: quella di indossarlo. O di non farlo affatto. Perché in un’epoca dove tutto è iper-visibile, poter decidere come apparire — e se apparire — è già una forma di libertà.
Il rossetto è tutto questo: bellezza, storia, rivoluzione, vanità, ironia, identità. Ma soprattutto, è personale. Nessuno lo indossa davvero allo stesso modo. C’è chi lo mette con precisione millimetrica e chi lo sfuma con le dita. Chi lo sceglie ogni giorno uguale a se stesso, e chi cambia tonalità come cambia umore.
Io, per esempio, lo metto anche quando non serve. Quando non esco. Quando nessuno mi vede. Forse perché non è un gesto per gli altri, ma per me. Per ricordarmi che ci sono. Che merito di brillare, anche solo per un istante, anche solo per me stessa.
Ecco perché il rossetto resiste, anche in un’epoca di skincare minimal e beauty routine invisibili. Perché, in fondo, non è mai stato solo un prodotto. È stato — e resta — un modo per dire chi siamo, senza dover dire niente.
Un piccolo gesto. Ma capace, da sempre, di fare grandi rivoluzioni.